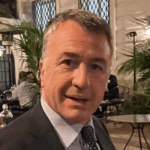La serie Netflix non si limita a ricostruire i delitti, ma svela la trama sociale, politica e psicologica che ha avvolto per decenni il primo serial killer italiano.
Chiunque abbia vissuto in Italia tra gli anni ’70 e ’90 ha sentito almeno una volta nominare il Mostro di Firenze. Un nome che evoca paura, mistero e orrore, diventato sinonimo di uno dei casi criminali più agghiaccianti e irrisolti della nostra storia. Ma quanto ne sappiamo davvero? E quanto è rimasto nascosto, sommerso in quella palude di piste confuse, errori giudiziari e inquietudini mai sopite?
A questa domanda prova a rispondere “Il Mostro”, la nuova serie Netflix diretta da Stefano Sollima, che affronta il caso da un punto di vista completamente diverso rispetto alla narrazione mediatica tradizionale. Non è una docuserie e non è un crime convenzionale: è un viaggio dentro le ombre più profonde del nostro Paese, attraverso una regia sobria e una scrittura lucida che disturba, appassiona e interroga.
La pista sarda, l’Italia degli anni bui e un mistero mai risolto
L’aspetto più sorprendente della serie è la scelta di evitare i nomi più noti legati al caso – da Pacciani ai Compagni di Merende – per concentrarsi invece su una fase iniziale e spesso dimenticata dell’indagine: la cosiddetta pista sarda. È da lì che parte la storia criminale del Mostro, e lì si trovano gli indizi più disturbanti sul contesto in cui quei delitti hanno potuto germogliare.
La narrazione di Sollima non si limita alla cronaca: costruisce un quadro sociale e culturale dell’Italia degli anni ’60 e ’70, segnata da trasformazioni profonde, tensioni latenti e istituzioni incapaci di vedere con chiarezza. L’arma del delitto – una Beretta calibro 22, sempre la stessa – diventa un simbolo che lega otto duplici omicidi, per un totale di sedici vittime, tutte uccise in zone isolate della campagna toscana, sempre con una brutalità crescente.

Il killer eliminava gli uomini per colpire direttamente le donne, spesso con atti di dissezione raccapriccianti. Una modalità così specifica da suggerire una ritualità, un’ossessione mai del tutto compresa. Il primo omicidio ricondotto al Mostro risale al 1968, ma solo successivamente fu ricollegato alla lunga scia di sangue che avrebbe terrorizzato l’Italia per oltre 17 anni.
Una regia rispettosa, una scrittura spietata, un’Italia che si guarda allo specchio
La forza della serie sta nella sceneggiatura, capace di cambiare punto di vista a ogni episodio. Le stesse scene vengono riproposte da angolazioni differenti, con dettagli che assumono nuovi significati in base allo sguardo che li osserva. È una scelta narrativa efficace, che riproduce fedelmente la confusione e la frustrazione di chi ha seguito il caso per decenni, vedendo ogni pista sfaldarsi a pochi metri dalla verità.
La regia di Stefano Sollima è meno spettacolare del solito, ma volutamente pulita, asciutta, puntuale. Nelle scene di quotidianità, si affida al potere del dettaglio, mentre nei momenti più duri – gli omicidi – mantiene una distanza rispettosa, senza indulgere nella morbosità, ma rimanendo fedele agli atti processuali e ai rapporti investigativi.
C’è un costante senso di smarrimento, di impotenza, di memoria distorta, che accompagna lo spettatore episodio dopo episodio. Non ci sono certezze, solo ombre, ambiguità, possibili colpevoli che svaniscono, e la sensazione, terribile, che la verità non verrà mai davvero a galla.
Il Mostro non è solo un racconto di sangue. È un’analisi di un’Italia che, ancora oggi, fatica a fare i conti con il proprio passato oscuro. Un Paese che ha costruito mostri pubblici e privati, spesso senza riuscire a distinguere gli uni dagli altri. Che ha trasformato le sue paure in titoli di giornale e le sue indagini in labirinti giudiziari.
Nel 2025, questa serie arriva come atto di coraggio narrativo: rifiuta la comfort zone delle ricostruzioni lineari e ci chiede invece di entrare nel caos, nel dubbio, nella zona grigia della memoria collettiva. Non offre risposte, ma riapre domande che pensavamo di aver chiuso, e lo fa con una forma che richiama più il romanzo psicologico che il giallo classico.
E forse è proprio questo il suo merito più grande: non inseguire la soluzione, ma raccontare la complessità del mistero. Perché dietro la figura del Mostro c’è una società intera che ancora oggi si interroga, si protegge, si illude. E che, come allora, continua a non sapere tutto ciò che crede di sapere.