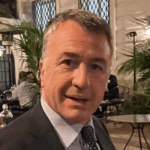Violenti temporali supercellulari colpiscono il Nord Italia: ecco cosa sono, dove si formano e perché possono diventare sempre più frequenti.
Una sequenza di temporali intensi ha attraversato l’Italia settentrionale tra la fine di agosto e i primi giorni di settembre 2025. Secondo IlMeteo.it, le aree più colpite sono state Lombardia, Piemonte e Liguria, con grandinate estese, raffiche di vento che hanno raggiunto velocità di burrasca e allagamenti improvvisi in zone urbane e rurali. I fenomeni sono stati identificati come supercelle, una tipologia di temporali particolarmente intensa, caratterizzata da una struttura interna rotante e dalla capacità di restare attiva per ore.
I modelli atmosferici elaborati da PRETEMP hanno evidenziato un aumento della vorticità nei bassi strati e una forte instabilità verticale, elementi che predispongono alla formazione di mesocicloni, il cuore pulsante di ogni supercella. Il bollettino ha portato all’attivazione di un livello 2 di allerta per fenomeni estremi su buona parte del Nord Italia. Il fronte temporalesco, poi, ha esteso la sua traiettoria anche verso regioni del Centro come Toscana, Lazio e Campania, dove i fenomeni hanno causato danni ad infrastrutture agricole, colture distrutte e interruzioni di viabilità.
Cosa rende pericolose le supercelle
Le supercelle temporalesche sono tra i sistemi convettivi più temuti dai meteorologi. Si distinguono per la presenza di un mesociclone, ovvero una corrente ascensionale rotante al loro interno. Questo tipo di vortice si forma quando l’atmosfera è instabile e i venti cambiano intensità e direzione con la quota. Il fenomeno, noto come wind shear, crea le condizioni per una circolazione d’aria che alimenta e mantiene il temporale anche per diverse ore consecutive. Secondo il National Weather Service, la particolarità delle supercelle risiede nella loro capacità di separare nettamente i moti ascendenti e discendenti, evitando così il collasso della struttura. Questo le rende persistenti, capaci di muoversi su lunghe distanze e di generare eventi estremi in più fasi. L’identificazione radar è possibile grazie alla presenza del cosiddetto hook echo, una firma radar tipica della rotazione interna.

Le supercelle si dividono in due principali categorie: ad alta precipitazione (HP), che causano forti rovesci e allagamenti rapidi, e a bassa precipitazione (LP), spesso accompagnate da grandine di grandi dimensioni ma con scarse piogge. In entrambi i casi, le conseguenze possono essere devastanti. Secondo The Weather, una supercella può generare venti superiori a 300 km/h, grandine fino a 15 cm, downburst e, nei casi più estremi, tornado. In Italia, le colture agricole rappresentano una delle vittime più immediate: interi raccolti vengono distrutti in pochi minuti, con erosione dei suoli e danneggiamenti agli impianti. Ma l’impatto non si limita al settore agricolo. Le inondazioni lampo possono contaminare le falde acquifere, disperdere inquinanti e alterare in modo duraturo gli ecosistemi locali. Le aree boschive subiscono spesso schianti di alberi, mentre in zone urbane i danni interessano abitazioni, reti elettriche e infrastrutture stradali.
Dove si formano e cosa ci attende nei prossimi anni
Le supercelle non si formano ovunque. Richiedono condizioni molto specifiche, come aria calda e umida al suolo, aria più fredda in quota, una forte instabilità atmosferica e una certa disposizione topografica del territorio. La Pianura Padana, ad esempio, è una delle aree più vulnerabili in Europa, insieme all’arco alpino e alla fascia costiera del versante tirrenico. Le temperature elevate del Mediterraneo, specialmente durante le stagioni più calde, contribuiscono a creare un serbatoio di energia termica che, se incontrato da masse d’aria più fredde, può innescare celle temporalesche di tipo supercellulare. Questo è quanto osservato anche nel caso degli eventi tra agosto e settembre 2025. Secondo quanto riportato da Tempo Italia, il contrasto termico tra la superficie marina calda e le infiltrazioni fresche in quota ha giocato un ruolo chiave nell’attivazione dei fenomeni più violenti.
Uno studio pubblicato su Science Advances ha individuato un trend in crescita per le supercelle sull’Europa centrale e sul versante alpino italiano, con un incremento stimato del 50% in caso di aumento della temperatura globale di 3 °C. Le simulazioni dell’Università di Berna e dell’ETH Zürich hanno confermato una maggiore frequenza di questi fenomeni in contesti di riscaldamento climatico accelerato. Le zone più a rischio in Italia restano Lombardia, Veneto, Piemonte, ma anche alcune porzioni del Lazio e della Campania. Il Sud Italia, pur registrando una minore incidenza, non è esente da episodi localizzati, soprattutto in presenza di mare molto caldo o perturbazioni tropicalizzate. Per chi si occupa di pianificazione ambientale e tutela del territorio, la conoscenza delle zone più esposte può rivelarsi strategica: sia per rafforzare le difese locali, sia per ridurre la vulnerabilità dei sistemi naturali.