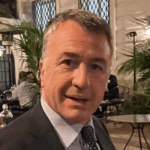Tra cookie, app traccianti e intelligenza artificiale, la nostra vita digitale è sempre più trasparente.
Ogni clic, ogni ricerca, ogni spostamento viene registrato. Non è paranoia, ma il modo in cui funziona oggi l’infrastruttura digitale globale. L’idea di avere una privacy online è diventata, per molti esperti, una finzione tecnica. Anche se accettiamo o rifiutiamo i cookie, disattiviamo la geolocalizzazione o cancelliamo la cronologia, i nostri dati continuano a circolare, scambiati tra aziende, piattaforme pubblicitarie, governi e soggetti privati. La trasparenza forzata è ormai la condizione normale di chiunque abbia un dispositivo connesso.
La raccolta dei dati è ovunque, anche dove non ce ne accorgiamo
Ogni volta che apriamo un sito o installiamo un’app, lasciamo tracce digitali. Non solo dati evidenti come nome, email o posizione, ma anche comportamenti: quanto tempo restiamo su una pagina, cosa guardiamo, dove clicchiamo, come scorriamo. Queste informazioni non vengono solo archiviate: vengono analizzate in tempo reale da algoritmi che ci profilano, ci classificano e ci predicono. Il sistema è pensato per essere opaco, con meccanismi che sfuggono alla percezione dell’utente medio.

Anche i metodi che promettono di proteggere la privacy — come le modalità anonime del browser o i sistemi anti-tracciamento — hanno limiti evidenti. Le tecniche di fingerprinting permettono di identificare un dispositivo anche senza cookie. Basta combinare dati come risoluzione dello schermo, sistema operativo, lingua del browser e tipo di font per ottenere una firma digitale unica.
Nel mondo mobile, la situazione è anche peggiore. App che sembrano innocue, come quelle per gestire file o scattare foto, possono raccogliere e inviare dati sensibili a server remoti. L’utente accetta i termini d’uso con un clic, ma raramente sa cosa ha davvero autorizzato. Alcuni studi indipendenti hanno rivelato che anche dopo aver revocato i permessi, molte app continuano a trasmettere dati in background.
In questo contesto, i social network giocano un ruolo chiave. Piattaforme come Facebook, Instagram, TikTok e X (ex Twitter) non sono semplici spazi di interazione: sono sistemi di sorveglianza commerciale progettati per trasformare ogni interazione in valore economico. Anche quando non pubblichiamo nulla, il sistema raccoglie informazioni su chi seguiamo, su cosa ci soffermiamo, su cosa ignoriamo. E costruisce modelli predittivi che finiscono nelle mani degli inserzionisti.
Intelligenza artificiale e big data: fine del controllo e nuove forme di sorveglianza
L’arrivo dell’intelligenza artificiale generativa, insieme alla diffusione dei big data, ha segnato un punto di non ritorno. Gli algoritmi non si limitano più a raccogliere dati: li interpretano, li collegano, li usano per generare nuove informazioni. Da un insieme apparentemente banale di dati anonimi si può risalire a identità, preferenze sessuali, convinzioni politiche, stato di salute. Una foto postata anni prima, una recensione lasciata su un sito, un like messo per caso possono riemergere e influenzare valutazioni su mutui, assunzioni o assicurazioni.
Anche le tecnologie di riconoscimento facciale contribuiscono a cancellare la distinzione tra pubblico e privato. Oggi basta una telecamera e un collegamento a un database per identificare una persona in pochi secondi, anche in mezzo a una folla. In alcune città europee e americane, queste tecnologie sono già usate per il controllo urbano, spesso senza un reale consenso informato.
Un altro elemento critico è il ruolo dei governi. Anche in democrazie consolidate, gli strumenti di sorveglianza di massa si sono moltiplicati, spesso giustificati da esigenze di sicurezza. Ma il confine tra prevenzione e controllo si fa sottile. Le rivelazioni di whistleblower come Edward Snowden hanno mostrato che l’architettura della rete è pensata per l’intercettazione, non per la riservatezza.
Anche dove esistono leggi sulla protezione dei dati, come il GDPR europeo, l’efficacia reale è limitata. Le grandi piattaforme trovano sempre modi per aggirare i vincoli, usando linguaggio ambiguo nei consensi o sfruttando meccanismi di default difficili da disattivare. La privacy, in pratica, resta sulla carta.
Le scelte individuali non bastano più: il controllo è nelle mani delle piattaforme
Molti utenti credono ancora che basti essere prudenti per mantenere un certo livello di riservatezza. Disattivare la posizione, usare motori di ricerca alternativi, evitare i social o navigare in modalità privata sembrano soluzioni sensate. Ma nel contesto attuale, questi accorgimenti non incidono davvero sulla portata della raccolta dati. Il problema non è più cosa scegliamo di condividere, ma quello che viene raccolto a prescindere. Le piattaforme digitali impongono ambienti chiusi, dove anche le impostazioni sulla privacy sono disegnate per essere complesse e scoraggiare il controllo effettivo. La logica è chiara: più dati si raccolgono, più è possibile profilare, vendere, influenzare. Anche le richieste di cancellazione, sebbene previste da alcune leggi, si scontrano con tempi lunghi, procedure opache e database paralleli che non garantiscono la reale eliminazione dei dati. La privacy non è più una scelta individuale, ma un problema sistemico che riguarda l’architettura stessa della rete.